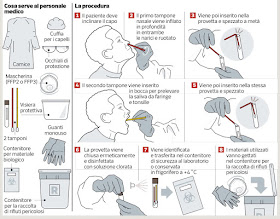Ci siamo addentrati lentamente e con crescente consapevolezza in questa configurazione straordinaria ed eccezionale. Non so se abbia dato alla luce qualcosa di nuovo o semplicemente alcune cose siano state messe tra parentesi e si sia ridotto all'essenzialità ciò che vigeva già. Nella lungimiranza del tempo di una civiltà, questo calarsi non è stato che un attimo, ma la sensazione è di uno sprofondamento lento, una rarefazione progressiva e irregolare, un congelamento a scatti, discontinuo ma prolungato.
Ed ora? Noi amici, vicini, coetanei, colleghi, passanti, parenti ci guardiamo come corpi soprattutto, assolutizzati nella malattia probabile e immaginata; sorvegliamo i nostri starnuti, i nostri colpi di tosse, se ci asciughiamo col fazzoletto e poi lo gettiamo subito, se tossiamo nell'incavo del gomito, se stringiamo la mano. Il nostro gruppo di amiche con bambini piccoli è passato in tre settimane dalle riunioni festose in privato (Carnevale in casa), ad abbracci nonostante tutto, fino ad abbracciarci-anche-no per epilogare in un “meglio non vedersi più”. Il progressivo allontanamento a livello generale è stato riprodotto in minima scala nel rapporto con la mia amica. Il mio bambino piccolo di tre anni cosa avrà capito del perché non può più vedere il suo amichetto preferito? Siamo corpi, ma anche oggetti, possibili traghetti di un male, anch'esso un oggetto, benché invisibile, impalpabile, ma concretissimo e silentemente cattivo. Arriva e deturpa, uccide, toglie. Siamo guardinghi, ci analizziamo, ma allo stesso tempo partecipi di uno stesso sentire.
Ci sono azioni che ci fanno recuperare provvisoriamente la nostra dimensione di esseri sociali. Posso scorgere dalla finestra la signora del balcone distante un centinaio di metri da me, percepire solo la sua sagoma, eppure sapere per certo che ha paura quanto me, che gioirebbe come me ad un cenno. Lo dimostrano le iniziative come quelle degli arcobaleni del “tutto andrà bene” e le jam session fra finestre. Le finestre assolutizzate in un affaccio sul mondo, l'unico o quasi. Il paesaggio si restringe, fino a far mancare l'aria, coincide con il panorama che si inquadra dalla finestra, dal balcone. Fuori è, se non un non-luogo, perché per costituzione sarebbe impossibile, una serie di luoghi sospesi, inabitati; paesaggi inutili, non visti, privati di relazione con l'uomo, sottratti all'uomo, non attraversati. La casa per contro diventa un iper-luogo, iper-abitato, al centro di tutto: per chi lavora a casa è anche luogo di lavoro. Per chi insegna è un disastro, diventa la classe intera, il collegio, l'interclasse. Per chi non ha figli piccoli diventa luogo di dispendio di cure dettagliate e senza scadenza, senza limiti di tempo. Pulizie minuziose, riparazione di quel piccolo soprammobile che giace frantumato sulla mensola da mesi. Luogo di cura. Per chi ha i bimbi piccoli, è il tempo mamma che diventa senza confini, un regalo di immensità, ma allo stesso tempo spiazzante. Che tipo di tempo devo passare con mio figlio, che prima vedevo solo quando il lavoro lo consentiva ed era finalizzato alle incombenze vitali, nutrire, lavare, vestire addormentare? Nelle chat delle mamme girano proposte di attività da svolgere insieme ai propri figli. Riprendere il ritmo insieme, divertirsi, arrabbiarsi, raccontare, ascoltarsi, ma non meramente passare il tempo con loro diventa il vero nucleo creativo di questi giorni a casa con lui.
Se la socialità è vietata, si implorano occasioni per uscire. Al momento di uscire, una forte incertezza. La spesa. Indosso da giorni gli stessi pantaloni macchiati della tempera usata per dipingere l'arcobaleno. Non sono sporchi, sono macchiati di tempera. In casa ho deciso di tenerli. Mio marito che lavora da casa gioisce perché anch'egli non ha dovuto cambiarsi d'abito tutti i giorni, e sistemare bene il risvolto dei pantaloni. Cambia dunque la mise, e anche la postura. Ogni giorno mi sono pettinata e truccata, non mi sono lasciata andare, ma è venuta meno la richiesta sociale del vestiario impeccabile. Decido di trasferire questo nuovo stato all'esterno. Esco con i pantaloni macchiati di verde. E di blu. Una certa angoscia mi ha preso: chi troverò, cosa troverò, come interagirò? Esco in auto, autocertificazione alla mano, percorro strade deserte. Al semaforo prima del supermercato l'angoscia è troppa: mi viene da piangere. Persone scendono dall'auto, si sistemano la mascherina e si avviano all'ingresso. La mia città sta soffrendo, vuoi per la preoccupazione del contagio, vuoi per l'ansia da reclusione; la solitudine degli anziani che vanno lo stesso a fare la spesa anche se i figli si offrono di andarci al posto loro, diventa grande come il cielo. Parcheggio, infilo i guanti di gomma, prendo il carrello. Dentro, il balletto per mantenere il metro di distanza. Incontro un amico che di solito mi abbraccia con un certo mio disagio. Oggi no, mi saluta freddamente e fugge via, aggrappato al carrello, con la mascherina schiacciata che gli deforma la faccia. La cosa strana è che dopo un po' che sono dentro (ho progettato una bella scorta e fare la spesa aspettando che il prossimo si allontani per prendere il suo posto di fronte allo scaffale prende tempo) il disagio si minimizza. È come se cercassi di riportare tutto alla normalità, come se non sopportassi questa eccezionalità. Poco dopo entrerò in un altro supermercato più grande perché le scorte di carne nel primo erano esaurite e mi rendo conto di muovermi come per far mostra di una certa expertise, di saperci fare con questa meccanica della distanza. In questo supermercato più grande mi fa impressione l'addetto alla disinfezione del corrimano della scala mobile: tiene costantemente uno straccio appoggiato sul corrimano scorrevole e ritmicamente vi spruzza sopra un disinfettante.
A casa, mentre scarico l'auto della mastodontica spesa, passa una coppia di anziani a piedi, in passeggiata. Ci diciamo buongiorno. Lui mi guarda sgranando due occhi di evidente congiuntivite e non parla subito, la moglie si trattiene alle sue spalle. Poi vince il timore e mi chiede della mia esperienza al supermercato: se si fanno code, e dove. Io li rassicuro che per ora il supermercato era più vuoto di come non l'abbia mai visto. Altre poche battute, tenere, gentili. Tre corpi che si ricongiungono, quasi scusandosi, grati vicendevolmente per i sorrisi.
Castano Primo (MI), 31 marzo 2020
Alessandra Mainini
Studentessa del Corso di Laurea in Scienze Antropologiche ed Etnologiche
Castano Primo (MI), 31 marzo 2020
Alessandra Mainini
Studentessa del Corso di Laurea in Scienze Antropologiche ed Etnologiche
Università Milano Bicocca
Continuiamo con questo post la pubblicazione dei contributi ricevuti da studenti e studentesse di antropologia interessati a condividere il loro punto di vista sulla situazione che stiamo attraversando. Il blog intende così proporsi come uno spazio di ascolto e confronto tra studiosi che si trovano in fasi diverse del loro percorso formativo e professionale.
Per inviare il vostro contributo, scrivete a: anthroday@gmail.com.
Il blog è curato dal gruppo di lavoro del World Anthropology Day - Antropologia pubblica a Milano.